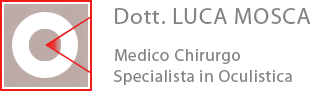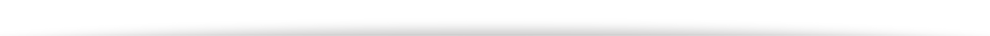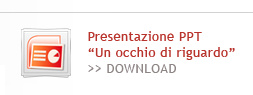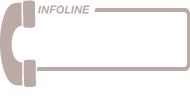- Avete problemi di offuscamento della vista?
- Avete problemi di abbagliamento?
- Vi sembra di vedere peggio in condizioni di scarsa luminosità o al contrario quando siete in piena luce?
- Avete notato un calo della vista da lontano ed un miglioramento di quella da vicino?
Tutti questi sono possibili sintomi di cataratta!
Che cos’è la cataratta?
Pensate che il nostro occhio è composto di più parti, una di queste è una lente che si chiama cristallino. Quando il cristallino si opacizza, si ha la cataratta. Allora la vista diminuisce e si fa più appannata, si riescono a vedere meno lettere del normale e quelle che si vedono non sono nitide, ma opache.
Qual è il rimedio per questa condizione?
L’unico è l’intervento chirurgico.
Negli ultimi 30 anni noi oculisti abbiamo assistito ad una RIVOLUZIONE, che ha riguardato tutte le fasi di questo INTERVENTO:
- QUANDO INTERVENIRE
- CHE TIPO DI ANESTESIA EFFETTUARE
- QUALI FARMACI ASSUNTI DAL PAZIENTE È NECESSARIO SOSPENDERE
- CHE TIPO DI INTERVENTO EFFETTUARE
- CHE TIPO DI LENTE IMPIANTARE
- QUALE TERAPIA POST-OPERATORIA PRESCRIVERE
- QUALI INDICAZIONI POST-OPERATORIE SEGUIRE
Analizziamo allora le varie fasi di questa rivoluzione:
1. QUANDO INTERVENIRE:
Prima non potevate scegliere quando operarvi, oggi sì.
Mi accade spesso che i pazienti affetti da cataratta mi chiedano: “Dottore, la mia cataratta è matura per essere operata?”.
Si esprimono così perché in passato si doveva aspettare che la cataratta fosse appunto “matura”, cioè si attendeva che il paziente vedesse molto poco. Chi, invece, aveva una cataratta iniziale non aveva altra scelta che sopportare i disagi e attendere che la vista calasse.
Oggi invece non è più così: se non riuscite a sopportare i fastidi derivanti dalla cataratta, potete decidere di sottoporvi all’intervento, senza più attendere.
Con le moderne tecniche la scelta della tempistica dell’intervento dipende esclusivamente dalla gravità dei disturbi che avvertite o dalla presenza di problemi che a volte si associano alla cataratta (ad esempio un aumento della pressione oculare). La questione, perciò, è molto cambiata rispetto al passato.
Vi suggerisco quindi di non perdere tempo e di farvi operare.
Dov’è il motivo di questa differenza tra il prima e il dopo? Perché in passato si doveva aspettare ed oggi no?
Perché è cambiato il tipo di intervento: le vecchie tecniche chirurgiche richiedevano che il cristallino con cataratta fosse estratto intero e per farlo la cataratta doveva essere dura e il taglio che consentiva l’estrazione doveva essere di notevoli dimensioni.
Oggi, invece, agiamo in questo modo: per estrarre la cataratta utilizziamo un strumento, il facoemulsificatore, che consente la sua frantumazione ed aspirazione attraverso una piccolissima incisione (circa 2 mm); di conseguenza riusciamo ad intervenire molto meglio quanto meno la cataratta è dura ed avanzata, perché è più facile rimuoverla. In questo modo riusciamo ad evitare che le altre strutture dell’occhio corrano maggiori rischi di essere danneggiate.
Come ci siamo riusciti? Pratichiamo dei tagli molto più piccoli che in passato e non dobbiamo più compiere le manovre di compressione che prima erano necessarie per estrarre il cristallino.
2. CHE TIPO DI ANESTESIA EFFETTUARE:
Prima peribulbare, oggi topica.
Il vecchio intervento di cataratta, a causa della sua invasività, richiedeva un’anestesia peribulbare, cioè un’iniezione dell’anestetico intorno all’occhio, per indurre la paralisi dei movimenti oculari e la completa assenza di sensibilità. Come è facile immaginare queste punture incutevano molta paura ed ancora oggi la maggior parte dei pazienti non accetta di buon grado questo tipo di anestesia.
Attualmente le iniezioni peribulbari sono praticamente abbandonate, a meno di casi particolari. Come anestetizziamo allora l’occhio? Utilizziamo un collirio anestetico somministrato più volte, agiamo cioè in anestesia topica.
In questo modo otteniamo che il paziente non avverta dolore, ma solo sensazione di contatto o di pressione, e che sia in grado di muovere liberamente l’occhio.
Chiediamo, però, di collaborare e mantenere una posizione fissa per la buona riuscita dell’intervento.
Mi capita spesso che i miei pazienti abbiano timore di non riuscire a comportarsi in modo adeguato. Mi chiedono infatti: “e se non riesco a tenere l’occhio fermo?”. In realtà non bisogna avere paura, perché è più semplice di come possa sembrare: basta fissare la luce del microscopio e seguire le indicazioni del chirurgo.
Con l’anestesia topica siamo riusciti ad ottenere due tipi di vantaggi: abbiamo evitato le possibili complicanze che derivano da un’iniezione nell’orbita (sanguinamenti, traumi a muscoli e nervi, possibilità di lesioni dirette dell’occhio) ed abbiamo annullato il tempo di attesa per il recupero dei movimenti oculari.
3. QUALI FARMACI ASSUNTI DAL PAZIENTE È NECESSARIO SOSPENDERE:
Il paziente che deve essere sottoposto all’intervento può, e in molti casi deve, assumere tutti i farmaci della sua normale terapia. Fondamentale ad esempio è assumere la terapia per la pressione arteriosa, al fine di evitare sbalzi pressori al momento dell’intervento.
Bisogna considerare che qualsiasi intervento chirurgico è un fattore stressante e in soggetti predisposti la pressione sale facilmente a valori critici per la sicurezza dell’intervento ed in alcuni casi per la salute stessa del paziente.
Le uniche eccezioni riguardano i farmaci anticoagulanti, che devono essere sostituiti opportunamente, e i farmaci per l’ipertrofia prostatica e la ritenzione urinaria, che vanno sospesi a partire da un mese prima dell’intervento.
4. CHE TIPO DI INTERVENTO EFFETTUARE:
Facoemulsificazione o femtocataratta.
Attualmente utilizziamo due tecniche di estrazione della cataratta: la facoemulsificazione e la femtocataratta. Entrambe sono tecniche moderne, sicure ed efficaci. Qual è allora la differenza tra le due? Con la seconda tecnica, che prevede l’utilizzo di uno strumento laser, l’intervento è più preciso e meno traumatico, ma anche più costoso.
La preparazione è uguale in entrambi i casi. Ecco come agiamo: somministriamo più volte al paziente farmaci che inducono la dilatazione della pupilla e che anestetizzano l’occhio. Successivamente il paziente viene posizionato sul letto operatorio dove monitoriamo la pressione sanguigna, il ritmo cardiaco e la saturazione dell’ossigeno. Isoliamo poi con un telino sterile l’occhio da operare e lo teniamo aperto con uno strumento apposito per poterlo disinfettare.
Dopo la fase di preparazione, comincia l’intervento vero e proprio.
Nell’intervento di facoemulsificazione effettuiamo un’incisione a valvola auto-chiudentesi di circa 2 mm, che non richiederà punti di sutura al termine dell’intervento. Vi chiederete come sia possibile non chiudere con dei punti una ferita nell’occhio. Ebbene dipende dal tipo di taglio effettuato. Tagliamo, cioè, in modo non perpendicolare alla superficie, ma in senso obliquo: col taglio perpendicolare infatti la semplice pressione interna dell’occhio indurrebbe un suo svuotamento, con quello obliquo invece la pressione fa in modo che il lembo inferiore si appoggi su quello superiore, inducendo una chiusura meccanica, senza dover ricorrere ai punti. In seguito, con l’ausilio di una micropinza, eseguiamo un’apertura circolare nella parte anteriore della capsula del cristallino (la sottile pellicola che avvolge questa lente). Attraverso questa apertura, detta capsuloressi, e con l’ausilio di un sofisticato strumento ad ultrasuoni, il facoemulsificatore, frantumiamo la cataratta e la aspiriamo. A questo punto viene introdotta una lente (IOL: intra ocular lens) all’interno della capsula del cristallino ormai vuota, al fine di sostituire quella naturale rimossa. L’intervento è quasi al termine, basta iniettare un antibiotico all’interno dell’occhio come profilassi dalle infezioni.
L’intervento di femtocataratta richiede invece l’utilizzo di un innovativo laser con cui si eseguono le incisioni di ingresso, la capsuloressi e la frammentazione, mentre gli altri step chirurgici vengono eseguiti con le stesse modalità della facoemulsificazione. Questo laser, detto a femtosecondi, ha la capacità, in pochi secondi, di creare tagli di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione con la precisione dei millesimi di millimetro, senza provocare danni ai tessuti circostanti. L’introduzione di questo innovativo strumento permette di proseguire nel percorso di standardizzazione della tecnica chirurgica, rendendola sempre più sicura e meno dipendente dai possibili errori umani.
5. CHE TIPO DI LENTE IMPIANTARE
Uno degli ambiti in cui abbiamo registrato le maggiori innovazioni riguarda la lente intraoculare da impiantare.
Fino a poco più di trent’anni fa l’intervento non prevedeva l’impianto di lenti intraoculari, semplicemente perché non erano ancora state inventate. Il paziente operato di cataratta, quindi senza più cristallino nell’occhio, era costretto ad indossare pesanti occhiali o scomode lenti a contatto. Sono poi arrivate le prime lenti di PMMA, un tipo di plastica rigida. Queste lenti richiedevano quindi un taglio di ingresso di elevate dimensioni, che doveva essere chiuso con dei punti. Successivamente le lenti iniziarono ad essere prodotte con materiali morbidi, siliconici e acrilici, e potevano quindi essere piegate ed introdotte con delle pinze attraverso un taglio di minori dimensioni.
Allo stato attuale, con l’affinamento delle tecniche produttive, siamo arrivati ad utilizzare lenti che possono essere piegate ed iniettate con degli strumenti specifici attraverso incisioni di soli 2mm.
Dal momento che inseriamo nell’occhio del paziente una nuova lente trasparente, quindi non più opaca, sfruttiamo l’occasione per sceglierla di potere tale da correggere anche i difetti di vista eventualmente presenti e permettere così al paziente, oltre a tornare a vedere nitido, di non indossare più occhiali.
Oggi esistono vari tipi di lenti tra cui scegliere:
- Lenti Monofocali: permettono il ripristino di una visione nitida per lontano, grazie ad uno speciale calcolo che corregge i difetti di vista quali miopia ed ipermetropia. Non permettono invece di intervenire su astigmatismo e presbiopia
- Lenti Toriche: permettono di correggere i difetti astigmatici, miopici ed ipermetropici.
- Lenti Multifocali: grazie ad un particolare disegno della loro superficie, composta da un alternarsi di cerchi concentrici di potere diverso, per lontano e per vicino, permettono una buona visione per lontano e la correzione della presbiopia.
- Lenti Multifocali Toriche, permettono la correzione di tutti i difetti di vista
È ovvio che i pazienti molto spesso mi dicano: “Beh, allora usiamo sempre lenti multifocali toriche: correggono tutto!”. Purtroppo la scelta della lente non è così semplice: ad orientarla intervengono diversi fattori come le caratteristiche anatomiche dell’occhio, la differenza di costi delle diverse lenti e le esigenze del paziente. Alcune lenti possono avere costi elevati, ma possono essere determinanti nel migliorare la vostra vita. Non vi accontentate, perciò, di vedere male il mondo e, se dovete investire, fatelo sulla vostra vista.
6. QUALE TERAPIA POST-OPERATORIA PRESCRIVERE
Ogni oculista sceglie la propria terapia postoperatoria. Io normalmente prescrivo colliri antibiotici, per evitare temibili infezioni, colliri antinfiammatori, per favorire la guarigione, e farmaci ipotonizzanti oculari, per evitare possibili aumenti della pressione. In casi particolari consiglio l’assunzione anche per via generale di antibiotici e antinfiammatori per aumentarne l’efficacia e ridurre al minimo le possibili complicanze post-operatorie. La durata della terapia postoperatoria varia dai 20 ai 30 giorni in base alla risposta del paziente, per questo è fondamentale che si effettuino visite oculistiche di controllo programmate.
7. QUALI INDICAZIONI POST-OPERATORIE SEGUIRE
Nel periodo successivo all’intervento, consiglio al paziente di bendare l’occhio solo per poche ore. Di solito raccomando l’utilizzo di lenti scure protettive non graduate quando si deve uscire o in caso la luce dia fastidio. Consiglio inoltre di evitare di toccarsi e sfregarsi l’occhio, di fare sforzi fisici e movimenti che possano far aumentare la pressione dell’occhio, come ad esempio piegarsi con la testa in avanti o sollevare pesi. Queste prescrizioni devono essere seguite per il tempo di durata della terapia farmacologica, quindi fino all’avvenuta guarigione.
Se volete chiarimenti o pensate di avere bisogno di una visita oculistica,
non esitate a contattarci ai numeri 3398784375, 3925051556
oppure inviate una mail all’indirizzo dott.luca.mosca@gmail.com